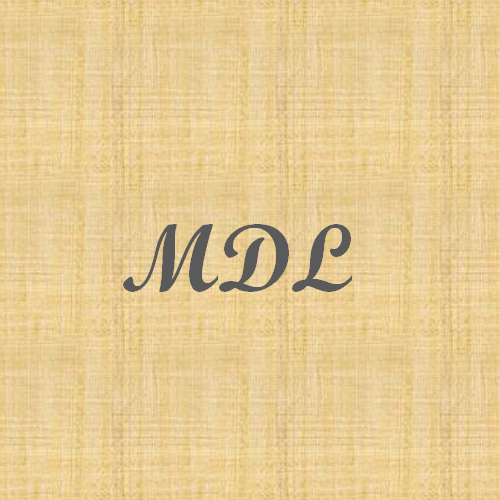Il primo articolo di questo mio neonato spazio virtuale non può che essere una riflessione su quella cultura classica che tanta parte ha avuto nella mia vita orientandone prima le scelte scolastiche e poi quelle professionali. Confesso subito di trovare molto urticante la questione dell’inutilità della cultura classica che ogni tanto rispunta con sempre rinnovata vis polemica e malcelato intento provocatorio. Il dato più avvilente della mai sopita querelle tra appassionati sostenitori del mondo classico e i suoi caustici detrattori, fieri paladini del primato della modernità, non è tanto che essa continui ad esistere, quanto che trovi la sua privilegiata espressione proprio nel nostro paese, che a quella cultura antica ha offerto anche lo spazio fisico del suo sviluppo.
L’entusiasmo con cui persino popoli culturalmente e geograficamente lontani dal nostro esplorano la cultura classica (non è forse sorprendente che una radio finlandese trasmetta ai nostri giorni un notiziario in latino?) acuisce lo sdegno di fronte all’ostinata resistenza di chi, nel nostro paese, si sottrae volontariamente alla gratificante fatica di un cammino a ritroso, ritenendolo solo un’inutile perdita di tempo.
Chi nega valore al passato, in nome di una sterile supremazia del presente tout court, è affetto da una grave miopia intellettuale contro cui suonano quanto mai efficaci le parole di Oscar Wilde: “Colui al quale il presente è la sola cosa presente, non conosce nulla dell’età in cui vive” (Intenzioni, 1891). Mordace come sempre il fine scrittore irlandese e forse non sarà un caso che fosse un profondo estimatore e un raffinato conoscitore della cultura classica.
Solo liberando il campo dalle facili banalizzazioni potremo cogliere la sostanza del mondo antico, tanto più preziosa quanto più distante da ogni forma sia di ammuffito passatismo sia di forzata e anacronistica riproposizione di modelli culturali oramai decaduti.
“L’antichità è un fecondo interlocutore permanente”, secondo l’incisiva definizione di Luciano Canfora, studioso di fama internazionale, che da quell’antichità ha sempre tratto fasci di luce potenti con cui rischiarare e dunque interpretare il presente.
La cultura classica costituisce le radici dell’uomo moderno, ne pervade la coscienza, ne condiziona anche inconsapevolmente il pensiero: ignorare quelle radici o addirittura reciderle, annullando gli strati sedimentati di una memoria secolare, significa esporre la società moderna ad un pericoloso stato di disorientamento pari a quello in cui si troverebbe un individuo che venisse improvvisamente privato dei suoi ricordi.
Partendo da queste premesse, ci si chiederà allora quale sia il significato attuale di una scuola come il Liceo Classico, che di quella cultura antica è il più importante depositario e veicolo di diffusione; quale sia insomma il valore aggiunto che esso propone alle nuove generazioni che percorrono il loro cammino scolastico nel terzo millennio.
Il Liceo Classico è una scuola coraggiosa, perché osa andare controcorrente e ha il potente afflato rivoluzionario di chi si ribella ai diktat delle convenzioni e delle mode effimere. In una società che ha nel profitto e nella velocità i suoi nuovi miti, il Liceo Classico propone valori antichi, ma sempre attuali, svincolati da ogni logica di pragmatica e immediata utilità. Il presente non basta, come suona il titolo del fortunato e illuminante libro di Ivano Dionigi (2016).
In una società che parcellizza il sapere in specializzazioni sempre più ristrette, il Liceo classico celebra l’unità profonda di una cultura che è matrice di tutte le discipline. Irretiti come siamo dalla rigidità settoriale con cui la cultura moderna innalza steccati divisori tra i vari campi del sapere, spesso perdiamo di vista un dato importante: la geometria, la matematica, la medicina, le scienze naturali, l’astronomia, la fisica hanno il loro punto d’inizio nel mondo antico, tanto quanto ce l’hanno la letteratura, il diritto, la storiografia, l’architettura, le arti figurative; esse sono in fondo le diverse prospettive di una stessa filo-sophia, intesa nella sua etimologica accezione di “amore per il sapere”.
Le lingue classiche, viste anche nel loro apparentemente arido nozionismo grammaticale, non sono un lusso che riguarda pochi eletti che si aggirano in una foresta di simboli indecifrabili: tutt’altro, esse sono anzi un mirabile strumento democraticamente offerto a molti per svelare antiche verità ed elaborare moderne connessioni.
Vista in questa prospettiva la traduzione, cuore pulsante degli studi classici, non è un’inutile fatica fine a se stessa, bensì un’occasione privilegiata per riscoprire quell’humanitas che dall’antichità giunge direttamente a noi come efficace antidoto contro ogni minaccioso processo di depauperamento di valori a cui il mondo contemporaneo sembra essere inesorabilmente sottoposto.
Avvicinare uno studente del terzo millennio ai testi antichi comporta dunque il suo coinvolgimento in un’operazione di alto significato culturale e formativo che lo aiuterà nel delicato processo di auto-identificazione e di acquisizione di un sistema di valori che ancora nel presente mantiene intatta la sua vitalità.
I testi antichi offrono pensieri, insegnamenti e riflessioni, che hanno ancora la capacità di emozionarci e di coinvolgerci, perché appartengono all’uomo di ogni tempo. Rinunciare a questo segmento antico del sapere, sarebbe una lacerazione profonda, una mutilazione assolutamente insanabile.
Gli studi classici sono come un investimento a lungo termine: gli interessi arriveranno dopo molto tempo, ma saranno di certo vantaggiosi e redditizi. Ecco, ho appena utilizzato una metafora presa in prestito dal mondo economico. Sono stata originale? No, niente affatto: ci aveva già pensato Seneca a parlare del mondo interiore dell’uomo con metafore di tipo economico. Noi moderni non saremo mai originali: i classici hanno già inventato tutto.
List