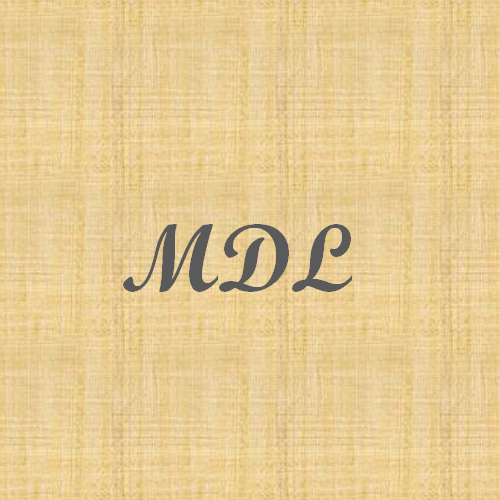La classicità ha pensato, narrato e gestito la natura in modo diversificato, intrecciando mitologia, filosofia, scienza, storia e prassi quotidiana.
1. Origini del cosmo
Tutte le cosmogonie antiche descrivono il passaggio dal chaos informe al cosmos ordinato. Nella Genesi il mondo scaturisce dal nulla per atto di un Dio creatore; nella Teogonia di Esiodo e nel Timeo platonico è un demiurgo ad articolare la materia pre esistente. L’opposizione tra “creazione” e “plasmatura” diventa paradigmatica delle differenze fra monoteismo biblico e politeismo ellenico.
Alla cosmologia si lega la storia dell’umanità: Esiodo parla di progressiva decadenza dalle età dell’oro al ferro, mentre altre tradizioni immaginano un progresso costante dalla barbarie alla civiltà tecnica. Poeti (Eschilo, Sofocle, Lucrezio) e filosofi amplificano e problematizzano entrambe le prospettive, costituendo il sottofondo etico del dibattito antico sul destino dell’uomo.
2. Natura benigna e matrigna
Per i Greci e i Romani la natura è insieme nutrice e minaccia: dà frutti, rigenera, ma scatena carestie, terremoti, tempeste. Comprenderla implica saper passare dal linguaggio religioso al ragionamento politico economico, dall’osservazione naturalistica alla tecnica agrimensoria.
3. Geografia, geostoria e determinismo climatico
Lo sguardo sul paesaggio genera una geografia ibrida (Erodoto, Strabone, Tolomeo) in cui mappa, racconto di viaggio e indagine etnografica si fondono. Per la Grecia la dura orografia e il mare diffuso spiegano la policentricità delle poleis e la precoce vocazione commerciale; per l’Italia la varietà peninsulare giustifica l’espansione romana. Da qui nasce il determinismo ambientale: Erodoto, Ippocrate e Aristotele attribuiscono alle condizioni climatiche le virtù e i vizi dei popoli (equilibrio greco, audacia nordica, ingegno orientale).
4. Impronta umana e prima coscienza ecologica
L’età classica mostra un’intensa azione di trasformazione: deforestazioni, canalizzazioni, miniere, uso del piombo, caccia indiscriminata. L’ideologia dominante è antropocentrica (Aristotele: la natura è “per l’uomo”), temperata solo dal rispetto sacrale per luoghi fulminati, boschi oracolari o sorgenti numinose. Pure in questo contesto emergono voci critiche: Erodoto segnala l’erosione del suolo, Platone denuncia la scomparsa delle foreste attiche, Seneca e Plinio temono l’avvelenamento da minerali pesanti.
5. Guerra, città, rumore
Con l’età ellenistica e imperiale, la pressione ambientale si sposta sulle grandi città: Roma soffre di traffico, rifiuti, smog e soprattutto di inquinamento acustico, che satirici come Giovenale e Marziale collegano a stress e malattia, sottolineando l’ingiustizia di una condizione che colpisce i poveri senza risorse per fuggire in campagna. La guerra, dal canto suo, devasta i campi, inquina fiumi e prosciuga boschi per i cantieri navali.
6. Mare, potenza e ambivalenza morale
Il Mediterraneo è al centro della parabola economico politica antica: la talassocrazia ateniese, celebrata dopo Salamina, diventa simbolo di democrazia e innovazione, ma anche fonte di corruzione, secondo Platone e Isocrate. Roma, vincitrice terrestre di Cartagine, si afferma poi anche sui mari, perdendo – lamentano Sallustio e Cicerone – la sobrietà dei mores antiqui.
7. Animali: uso, mito, pietà
Gli animali compaiono come forza lavoro, cibo, sacrificio, metafora morale. Accanto a un uso intensivo (caccia, giochi circensi) si sviluppa una corrente di pietà: Pitagora, orfici e, più tardi, Plutarco e Seneca propongono il vegetarianesimo in nome della metempsicosi o della solidarietà tra le specie viventi. Il bestiario mitico (dai cavalli parlanti di Achille ai mostri di Eracle) riflette paure e desideri di dominio, mentre la letteratura dei mirabilia alimenta l’immaginario con creature esotiche.
8. Le api, microcosmo ideale
Oggetto di studio scientifico (Aristotele) ed emblema etico politico (Virgilio, Cicerone, Seneca, Licurgo), le api incarnano l’esempio di una comunità disciplinata, laboriosa e solidale. Il loro miele è risorsa economica primaria, ma il loro valore simbolico supera la sfera materiale, offrendo un paradigma di armonia sociale che la riflessione classica propone all’uomo.
Conclusione
La civiltà greco romana alterna entusiasmo per il dominio tecnico sulla natura e timori per gli squilibri che tale dominio produce. Pur lontani da una moderna etica ambientalista, gli antichi hanno intuito la relazione fra ambiente, salute e giustizia sociale, lasciandoci un deposito di miti, diagnosi, soluzioni (religiose o politiche) che ancora interrogano il nostro modo di abitare il pianeta. Questa prospettiva storica, ampia e stratificata, invita il lettore colto a riconoscere sia la continuità dei problemi, sia la ricchezza di risorse concettuali che la classicità offre al dibattito contemporaneo.
Il contenuto di questo articolo è una sintesi della più ampia analisi contenuta alle pp. 2 sgg. del mio libro KyklosOrbis in cui vengono presentati anche testi greci e latini su questo interessante argomento.
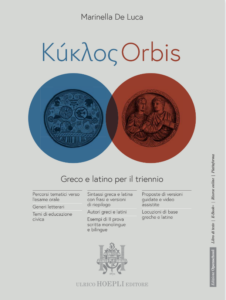
Per una sintesi sull’argomento con il corredo di immagini prodotte in piena collaborazione tra me e l’intelligenza artificiale:
https://gamma.app/docs/LA-NATURA-NEL-MONDO-ANTICO-biguchmc64jpu5q